 Nel post del 9 settembre scorso ho accennato a questo particolare motivo decorativo detto uma-no-me, "occhio di cavallo" in italiano. Si tratta di una serie di ovali concentrici disposti intorno ad una circonferenza, di solito posta a cornice di piatti. Si tratta di un motivo tradizionale antichissimo, probabilmente non è nemmeno nota la sua l'origine, è un tipo di decorazione talmente ben codificata fin dalla più remota antichità che ha richiesto l'intervento degli antropologici per essere decodificato; ecco, gli antropologi, secondo uno degli studi più accreditati le cose starebbero così: per propiziare la pioggia, necessaria ad buon raccolto, bisognava assicurarsi i favori dei dragoni, che vivono nell'acqua, ai dragoni piacciono le cavalle, mettere delle cavalle sulle rive dei fiumi, però, era un problema poiché queste erano una delle principali forze da lavoro e quindi, furono sostituite dalle raffigurazioni dei loro occhi; chiaro? spero di si; vero? probabile; quanto meno verosimile; gli antropologi ricercano motivi pratici, legati alla vita quotidiana, per spiegare aspetti culturali. Il signor Osugi (che si legge con la g di gatto, noi scriveremmo Osughi) però, ha un'idea diversa; probabilmente diversa, non è un argomento facile; (tutte le foto di questo post riprendono il suo negozio, sotto c'è lui *); Osugi, dicevo, ci ha dato un'altra possibile interpretazione della decorazione a occhio di cavallo: secondo lui potrebbe trattarsi di una rappresentazione del cosmo; il signor Osugi non è antropologo ma ha passato la sua vita tra le ceramiche e si direbbe che lo abbia fatto con grande passione, il suo punto di vista è più che rispettabile; così è difficile, se non impossibile, sapere quale lettura sia quella vera, e magari è possibile che in qualche modo siano vere entrambe, comunque non è interessante fare confronti, quanto, invece, lo è ascoltare storie diverse. Osugi, inoltre, ci ha spiegato che, tradizionalmente, questi piatti avevano 3 o 5 o 7 occhi e che normalmente erano utilizzati in particolari cerimonie legate ai riti di passaggio dall'infanzia all'età adulta. Nei piatti contemporanei, però, questa regola del numero dispari sembra si sia persa. **]+* Se una o più foto pubblicate in questo post dovessero ledere i diritti e/o la privacy dei soggetti ritratti sarà sufficiente darcene comunicazione e le foto saranno immediatamente rimosse.
0 Comments
|
AutoriVesuvioLab Archivio
Ottobre 2023
Categorie
Tutti
|


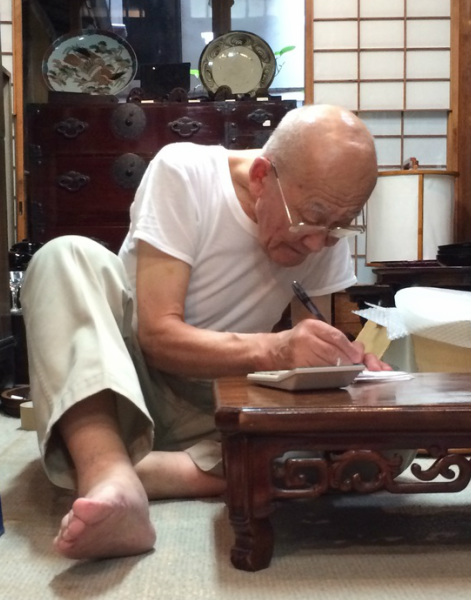
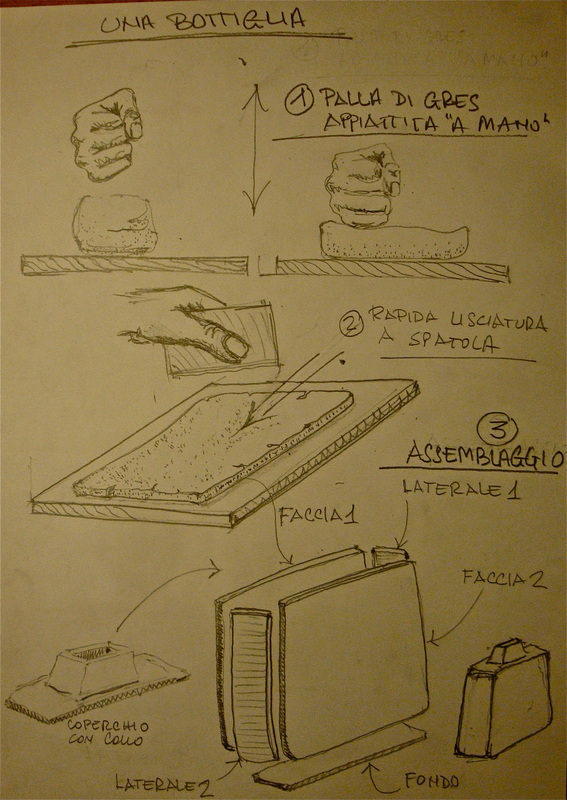



 Feed RSS
Feed RSS